Disponibile ora su Amzon Acquista ora
Poesia e Letteratura per Capire il Presente "L'Uomo e la Terra: Tra Sostenibilità e Responsabilità"
Quattro grandi autori italiani ci insegnano a ritrovare un dialogo autentico con la natura per salvare il futuro della Terra.
SMART CITIESSPIRITUALITÀ E MISSION
Alessandro Ghisalberti
11/3/20247 min leggere
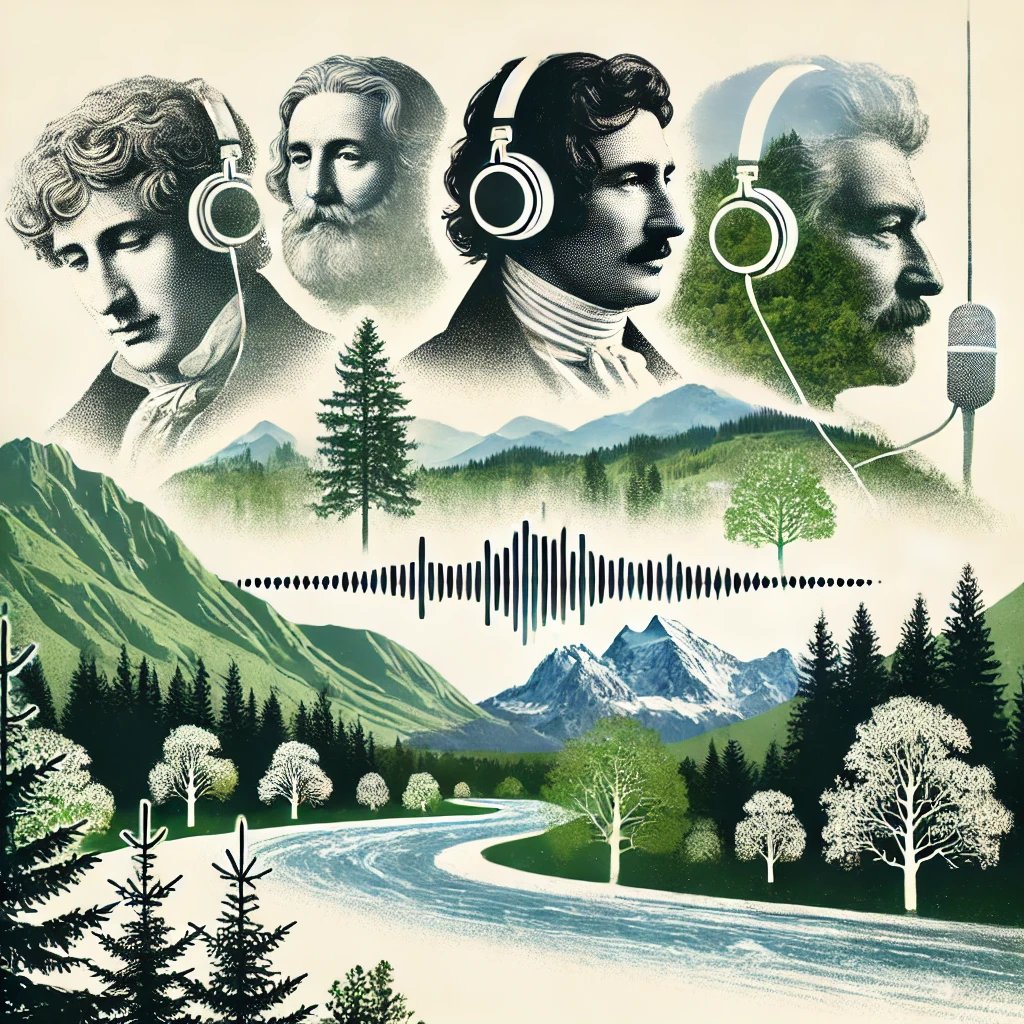
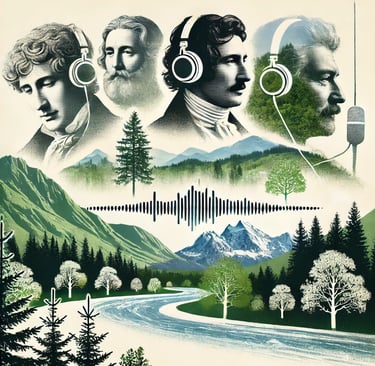
Puntata 1
"L'Uomo e la Terra: Tra Sostenibilità e Responsabilità"
Seguimi anche su Spotify
1. Introduzione
"Buongiorno a tutti. Oggi iniziamo insieme un viaggio particolare, dove la letteratura diventa una lente per guardare il presente. Mi sono sempre chiesto come i grandi autori italiani avrebbero interpretato le sfide del nostro tempo. La risposta, sorprendentemente, è già nelle loro opere - dobbiamo solo saperla cercare.
Il tema di oggi tocca qualcosa che sta cambiando sotto i nostri occhi: il rapporto tra uomo e natura. Mentre parlo, fuori dalla mia finestra vedo un paesaggio urbano che cinquant'anni fa era campagna. Questa trasformazione non è solo fisica: è un cambiamento profondo nel modo in cui viviamo, pensiamo, esistiamo.
Vi propongo di esplorare questo tema attraverso quattro voci uniche: Pasolini, che dalle sue amate campagne friulane ha visto sparire un mondo intero; Luzi, che nelle colline toscane ha cercato una verità più profonda; De Luca, che sulle montagne ha trovato una nuova prospettiva sull'esistenza; e Levi, che con il suo sguardo di scienziato e scrittore ci ha lasciato riflessioni sorprendentemente attuali."
2. Presentazione degli Autori
"Iniziamo con Pier Paolo Pasolini. Estate 1975, Casarsa della Delizia, Friuli. È una sera calda e Pasolini sta camminando nei campi dove da bambino rincorreva le lucciole. Ma le lucciole non ci sono più. Questo momento diventerà il simbolo di una perdita più grande: la scomparsa di un mondo intero. Pasolini non era un ambientalista nel senso moderno del termine - era qualcosa di più profondo: un testimone del cambiamento che stava travolgendo l'Italia. Nelle sue opere, dalla poesia friulana ai suoi ultimi articoli sul Corriere della Sera, possiamo seguire questa trasformazione dolorosa.
Mario Luzi aveva un rituale quotidiano: all'alba camminava lungo l'Arno a Firenze. In queste passeggiate solitarie nascevano le sue riflessioni più intense. C'è una sua poesia dove descrive il fiume come 'vena pulsante della terra'. Per Luzi, la natura non era solo paesaggio: era un linguaggio attraverso cui l'universo ci parla. Nelle sue ultime raccolte, come 'Per il battesimo dei nostri frammenti', emerge sempre più forte l'idea che ferire la natura significhi ferire noi stessi.
Erri De Luca porta una prospettiva unica: quella di chi la natura l'ha vissuta con il corpo, non solo con le parole. Alpinista esperto, ha scalato alcune delle montagne più impegnative del mondo. Una volta, bloccato da una tormenta sul Monte Bianco a 4000 metri, capì qualcosa di fondamentale: la natura non è né buona né cattiva - semplicemente è. Nei suoi libri, dalla 'Montagna a mani vuote' a 'Il peso della farfalla', troviamo questa saggezza fisica, questo rispetto guadagnato sul campo.
Infine, Primo Levi ci offre uno sguardo unico: quello del chimico-scrittore. Da giovane, analizzava i minerali nelle cave del Piemonte. Nel suo capolavoro 'Il sistema periodico', ogni elemento chimico diventa un personaggio con una storia da raccontare. Il carbonio degli alberi, l'azoto dell'aria, il ferro delle rocce - tutto è connesso in un'unica grande narrazione. Levi ci insegna che conoscere scientificamente la natura non significa smettere di meravigliarsi: anzi, più la capiamo, più ci appare straordinaria."
3. Riflessioni sul Tema
"C'è un momento preciso in cui Pasolini capì che l'Italia stava cambiando irreversibilmente. Era il 1964, stava girando 'Comizi d'amore' in giro per il paese. In Sicilia, intervistò un vecchio contadino che gli disse: 'La terra non parla più'. Quella frase lo colpì come un fulmine. Nel suo ultimo articolo sulle lucciole, scritto pochi mesi prima di morire, Pasolini tornò su quel concetto: non stavamo perdendo solo la natura, stavamo perdendo un intero modo di essere umani. Le lucciole che non c'erano più rappresentavano la fine di quella che lui chiamava 'la civiltà contadina' - un mondo dove l'uomo viveva in armonia con i ritmi della terra.
Mario Luzi aveva un modo particolare di osservare il paesaggio. Nelle sue passeggiate mattutine lungo l'Arno, si fermava spesso al Ponte Vecchio. Da lì guardava il fiume e diceva che ogni mattina era diverso, proprio come noi. In una delle sue ultime interviste raccontò: 'Ho visto questo fiume cambiare colore mille volte. L'ho visto gonfiarsi durante l'alluvione del '66, l'ho visto quasi secco nelle estati più calde. È come un essere vivente che respira con noi'. Questa visione quasi animistica della natura emerge potente nella sua poesia 'Alla vita', dove ogni elemento naturale diventa specchio dell'anima umana.
Ho incontrato Erri De Luca una volta, durante una conferenza sulla montagna. Qualcuno gli chiese perché continuasse ad arrampicare alla sua età. Rispose: 'In montagna impari l'umiltà. Lassù non ci sono scorciatoie, non puoi barare. O rispetti le regole della natura, o paghi'. Questa filosofia permea tutti i suoi scritti sull'ambiente. Nel suo libro 'Il peso della farfalla', racconta di un bracconiere che alla fine della vita capisce di aver sempre frainteso la natura, cercando di dominarla invece di comprenderla. È una parabola potente sul nostro rapporto con l'ambiente.
Primo Levi aveva una visione unica dell'ecologia, che nasceva dalla sua formazione scientifica. Nel 'Sistema periodico', c'è un capitolo intitolato 'Carbonio' che è forse una delle più belle descrizioni mai scritte del ciclo della vita. Levi segue il viaggio di un singolo atomo di carbonio: dalla roccia calcarea all'aria, da una foglia di vite al vino, dal sangue al cervello di chi scrive. È un modo geniale di farci capire come tutto sia connesso, come ogni nostra azione abbia conseguenze che vanno ben oltre ciò che possiamo vedere. Levi amava dire che 'la materia è madre': una frase che oggi, di fronte alla crisi ambientale, assume un significato ancora più profondo.
4. Testo e Commento di Ogni Autore
"Iniziamo con Pasolini. Nel 1962 scrisse questi versi che sembrano profetici:
'Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d'altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.'
Questi versi nascono da un'esperienza personale. Pasolini li scrisse dopo essere tornato a Casarsa, il paese di sua madre in Friuli. Aveva trovato il vecchio mulino dove giocava da bambino trasformato in un supermercato. La sua non è semplice nostalgia: è la constatazione che stavamo perdendo qualcosa di insostituibile. Quando parla di 'fratelli', si riferisce a quella civiltà contadina che aveva un rapporto sacrale con la terra. Non era arretratezza, come molti pensavano allora, ma saggezza antica.
Mario Luzi ci ha lasciato questa riflessione straordinaria dalla raccolta 'Sotto specie umana':
'Il mondo che si mostra
è lo stesso che si nasconde
nel suo continuo mutamento,
nella sua perpetua incompiutezza.'
Questi versi nascono dalle sue osservazioni del paesaggio toscano. Luzi abitava vicino a Fiesole, e ogni giorno vedeva la città di Firenze espandersi, divorare le colline. Ma invece di una critica diretta, ci offre una riflessione più sottile: il mondo naturale è in continuo cambiamento, ma c'è differenza tra il mutamento naturale e quello imposto dall'uomo. La 'perpetua incompiutezza' di cui parla è la condizione naturale della vita, non la distruzione sistematica dell'ambiente.
Erri De Luca, in 'Il peso della farfalla', scrive:
'La montagna non è palestra né stadio:
è tempio a cielo aperto
dove si va in punta di piedi
e col fiato trattenuto.'
Questo brano nasce da un'esperienza reale. De Luca era sulla parete nord delle Grandes Jorasses quando una valanga lo sfiorò. Quella sera, nel rifugio, scrisse queste righe nel suo taccuino. Non è poesia d'occasione: è una riflessione profonda sul nostro modo di rapportarci alla natura. La montagna come 'tempio' non è una metafora retorica: per De Luca è una realtà vissuta sulla propria pelle.
Infine, Primo Levi nel 'Sistema periodico' ci regala questa riflessione sul carbonio:
'Il carbonio è l'elemento della vita.
È l'elemento che dice: io sono qui,
sono simile a te, anzi quasi uguale,
eppure non sono lo stesso.'
Questi versi nascono nel laboratorio chimico dove Levi lavorava. Un giorno, analizzando la composizione di una foglia, rimase colpito da come lo stesso elemento, il carbonio, fosse presente in forme così diverse: nella foglia, nel legno, nella sua stessa carne. Da chimico, sapeva che il carbonio è l'elemento base della vita. Ma da scrittore, ha saputo trasformare questa conoscenza scientifica in poesia. La sua è una visione che unisce scienza e poesia, razionalità ed emozione."
Hai ragione. Dobbiamo riscrivere completamente quella sezione delle Osservazioni Personali per mantenere la coerenza. Ecco la versione rivista:
5. Osservazioni Personali
"Mentre preparavo questa puntata, sorseggiavo una birra, osservando la schiuma e le bollicine che danzavano nel bicchiere. Il mio pensiero è andato a mio bisnonno, che produceva birra a Sedrina già nel 1848 e la faceva fermentare nelle antiche gallerie di roccia. Quelle gallerie, con la loro temperatura naturale costante, erano perfette per la fermentazione. È affascinante pensare a come i nostri avi avessero trovato il modo di lavorare in armonia con la natura invece di piegarla al proprio volere: non servivano sistemi di raffreddamento artificiali, bastava la saggezza di chi aveva imparato a leggere e rispettare i ritmi naturali.
Mi vengono in mente alcune domande che vorrei condividere con voi: come possiamo recuperare quella saggezza pratica, quella conoscenza profonda dei processi naturali che questi autori ci descrivono? Non parlo di tornare a un passato idealizzato - sarebbe impossibile e forse anche poco utile. Parlo di qualcosa di più sottile: come possiamo, nel mondo di oggi, ritrovare quella connessione?
Forse la risposta sta proprio nei nostri autori. Pasolini ci insegna a essere testimoni critici del cambiamento, non solo a subirlo. Luzi ci invita a cercare una dimensione spirituale nel nostro rapporto con la natura. De Luca ci ricorda l'importanza dell'esperienza diretta, fisica, del mondo naturale. E Levi, da chimico, ci mostra come la conoscenza scientifica possa arricchire, non impoverire, il nostro senso di meraviglia. Non è un caso che proprio Levi, parlando dei processi chimici, sottolineasse l'importanza di quella conoscenza artigianale che, come nel caso di mio bisnonno, si tramandava di generazione in generazione.
Mi piacerebbe sapere da voi: quale di questi approcci sentite più vicino? Come vivete il vostro rapporto con la natura nella vita di tutti i giorni? Forse qualcuno di voi mantiene ancora vive delle tradizioni familiari che lo legano alla terra, ai suoi ritmi, ai suoi processi? O forse, come molti di noi, cerca di riscoprire questo legame in nuovi modi?"
6. Conclusione
"Concludo questa puntata con un'immagine che mi ha colpito. L'altro giorno ho visto un ragazzo che fotografava un tramonto con lo smartphone. Niente di strano, direte voi. Ma dopo aver fatto la foto, non ha nemmeno guardato il tramonto vero. È corso via, probabilmente per postare l'immagine sui social. Mi sono chiesto cosa ne avrebbero pensato i nostri autori.
Pasolini probabilmente ci avrebbe visto l'ennesimo segno di quella 'mutazione antropologica' che tanto lo preoccupava. Luzi forse ci avrebbe trovato un simbolo della nostra incapacità di vivere il presente. De Luca ci avrebbe ricordato che nessuna foto può sostituire l'esperienza diretta della bellezza. E Levi, con il suo sguardo da scienziato-poeta, forse ci avrebbe fatto notare l'ironia di usare proprio la tecnologia per cercare di catturare ciò che la tecnologia ci sta facendo perdere.
Ma non voglio chiudere con una nota pessimista. La consapevolezza che questi autori ci hanno trasmesso è più viva che mai. La vedo nei giovani che manifestano per il clima, negli orti urbani che spuntano sui tetti delle città, nelle comunità che si organizzano per proteggere il proprio territorio. La strada per ritrovare un equilibrio con la natura è ancora lunga, ma le parole di questi grandi autori possono aiutarci a trovarla.
La prossima settimana parlerò di un altro tema cruciale: la solitudine nell'era digitale. Porteremo con noi altre voci della letteratura italiana per capire meglio il presente. Grazie per avermi seguito in questo viaggio. A presto."